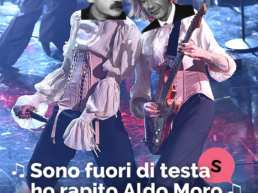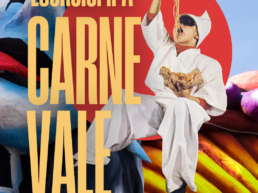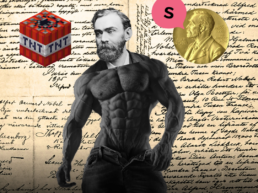Da Tylor a Parthenope l’antropologia è uno degli underdog del sapere. Bistrattata a scienza delle merendine, ritrova tuttavia una propria dignità e ragion d’essere nella cinematografia del regista napoletano.
Un nuovo trend culturale, un po' "chiattillo", un po' radical chic
Paolo Sorrentino da Napoli ne ha fatta un’altra delle sue: con la sua mai banale e poetica macchina da presa ha reso l’antropologia una tendenza social. Si, certamente Levi-Strauss era un figo, ma prima di Parthenope, la tua amica, vomerese o pariolina, parlante in corsivo che fuma Iqos non avrebbe mai postato una Instagram storie inerente al campo di studi di quell’allegro ebreo parigino. Ecco, al di là del meme proviamo a comprendere cosa sia questa fantastica e complessa scienza per la quale quelle giovani donne, che un tempo avrebbero citato Bukowski, impazziscono.
Una scienza nata razzista
L’antropologia è una scienza nata dalla violenza. Nel tardo XIX secolo il mondo era più o meno organizzato sullo sfruttamento imperialista e coloniale, un principio politico semplice e remunerativo che rese l’Occidente il centro del mondo. La fiducia nei mezzi economici, militari e industriali, portò le classi intellettuali dell’epoca a credere che l’umanità avrebbe raggiunto presto dei livelli di progresso enormi.
Darwin aveva in quegli anni pubblicato il saggio L’origine della specie, un testo rivoluzionario per l’umanità almeno quanto Lino e Alessia lo sono stati per Temptation Island. Darwin e i darwinisti sostanzialmente affermavano: gli uomini discendono dalle scimmie, dalle quali si sono differenziati con il tempo, sfruttando dei vantaggi evolutivi legati alla capacità d’adattamento della specie all’ambiente circostanziale. I cambiamenti si sarebbero poi contraddistinti come stadi evolutivi, degli step, una cosa tipo i Super Saiyan di Dragon Ball. L’ominide si è evoluto in australopiteco, (come Goku in super saiyan di primo livello), e così via, fino ad arrivare al grado massimo di evoluzione, l’uomo caucasico, rigorosamente bianco, anglosassone e protestante, o tutt’al più francese.
Nell’università europee ed americane evoluzionismo e positivismo si diffusero a macchia d’olio, e ci si iniziò a chiedere se fosse possibile ritrovare, nelle varie società del mondo, delle forme di uomo che potessero darci testimonianza dei vari stadi evolutivi, degli uomini non evoluti, ancora legati ad usanze barbare, sintomo di un mancato sviluppo dai tratti biologici e culturali. Essendo buona parte di queste differenze, secondo le nozioni scientifiche dell’epoca, legate a dettami di natura prettamente biologica, gli stadi evolutivi venivano identificati con le razze.
Nel Regno Unito, l’accademico Edward Burnett Tylor specializzato in scienze biologiche e botaniche pubblicò nel 1871 Primitive Culture, dando così inizio all’epopea dell’antropologia. Una bellissima e profondissima scienza basata su presupposti razzisti almeno quanto quelli di tuo nonno Amilcare, il quale non è nostalgico ma ha sempre amato i treni puntuali.

La redenzione del sapere antropologico
Ma l’antropologia da verme orribile, nato dall’ottocentesca violenza atroce ed imperialista, si è mutata poi in una farfalla bella almeno quanto quella tatuata nell’interno coscia di Belen. A cambiare le carte in tavola è stata una serie di accademici, di origine ebraica, tra Francia e Stati Uniti (Franz Boas, Marcelle Mauss, Claude Levi-Strauss solo per citare i più famosi).
Il Novecento ha aperto gli occhi sulle atrocità di cui gli euro-americani sono stati capaci: Verdun, Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Iraq, Afghanistan, Serbia, Bosnia. L’uomo bianco non è stato mai migliore degli altri, si è limitato all’essere diverso, e fortunatamente facciamo tutti schifo.
Queste menti rivoluzionarie hanno solo evidenziato quanto le modalità d’esecuzione dell’“essere” umani siano saldamente legate alla concezione culturale del reale: la concezione dell’essere uomo o donna, infante o anziano, vivo o morto, non è universale. La società di provenienza dei soggetti aiuta quest’ultimi ad auto rappresentarsi e autodefinirsi.
Il complesso di Edipo, ad esempio, non è universalmente valido allo stesso modo in ogni società: ad inizio Novecento un antropologo polacco naturalizzato inglese, tale Bronislaw Malinowski, si rese conto che in Oceania, sulle isole Trobriand, i maschietti non volevano inconsciamente ingropparsi la madre e mandare al creatore il padre, ma ingropparsi la moglie dello zio materno, o del parente materno maschio consanguineo più vicino, ed uccidere lo stesso.
Questa peculiare declinazione della categoria psicoanalitica edipica era sostanzialmente dovuta all’organizzazione comunitaria differente della società trobriandese, presso la quale la patria podestà sul bambino era esercitata tendenzialmente dal fratello della madre, mentre il padre biologico si limitava a fare le veci dello zio amicone, come tuo zio Enzo con cui fumi oppio mentre insieme guardate la nonna farsi la doccia dal buco della serratura della porta del bagno.

Andare oltre insieme all'altro
Il Novecento, in virtù delle catastrofi di cui l’Occidente è stato in parte responsabile, quali due guerre mondiali e il divorzio fra Al Bano e Romina, ha dunque segnato il passaggio dell’antropologia da scienza dura e razzista a scienza relativista ed antirazzista.
L’antropologia non è solo un vezzo accademico, ma l’indagine strutturata dei comportamenti individuali e collettivi nella misura in cui essi sono influenzati dalle culture di provenienza dei soggetti analizzati. Ad essa si è data nuova vita al fine di comprendere l’altro, i suoi usi, i suoi costumi, il suo modo di pensare, affiancandosi a tutti quei saperi rigidi e non, che analizzano quei fattori capaci di influenzare il comportamento umano.
È dunque vedere, o sforzarsi nel farlo: essere capaci di non biasimare quelle tribù presso le quali finire a letto tra fra cugini è normale, come nel caso degli abruzzesi, oppure comprendere perché in Congo i bambini siano pronti ad armarsi in violentissime milizie, o ancora il motivo per cui i boomer maschi etero cis cerchino di cogliere con la propria salsiccia il fiore di donne calde a cinque chilometri da loro.
L’antropologia è indagare ciò che non ci è comprensibile, per meglio capire chi siamo. Il dovere dell’antropologo è guidarci verso una visione ampia e non dogmatica, e quindi anche non violenta, volta a nutrirci di umanità, a fare dell’altro un elemento critico e pericoloso, non perché distruttivo, ma perché essendo diverso da noi, non potrà mai essere noi.
Non casualmente, in Parthenope, il padre putativo di una giovane studentessa degli anni Settanta, è lo sfacciatissimo e mai banale professor Marotta, interpretato da Silvio Orlando, il quale, affettuoso ma autorevole, abbatte muri ideologici per costruire degli enormi ponti dialogici fra noi e gli altri, non giudicando mai quest’ultimi, anche quando possono apparire grotteschi e fuori dalla usuale norma. L’antropologia è vedere, fare dell’altro specchio, per meglio comprendersi, e a volte redimersi.

2025-05-14
Finché legge non ci separi
Nel 1974, gli italiani furono invitati a rispondere a una questione…
2025-05-07
Roma è sempre stata la capitale cristiana?
Roma è sempre stata la capitale cristiana? Spoiler: no. In occasione del…
2025-03-16
Sono fuori di testa ho rapito Aldo Moro
Nel febbraio 2021 Damiano (non più dei Måneskin) cantava (più o meno) queste…
2025-03-04
Esorcismi a Carnevale
Il Carnevale è molto più di una festa: è il mondo che perde se stesso per…
2025-01-24
Garibaldi: sposo per un’ora
Da "eroe dei due mondi" a vittima di adulterio è un attimo: scopriamo insieme…
2025-01-06
La Befana è un essere demoniaco
La Befana, in termini antropologici, è molto più che una vecchia che fa alzare…
2024-12-23
Buon compleanno Gesù!
Per il suo... compleanno, ricostruiamo storicamente la vita di Gesù Cristo:…
2024-12-16
Natale con Stalin: da Troskij a Christian de Sica
Che collegamento ci può essere tra Iosif Stalin, l'assassinio di Lev Troskij...…
2024-11-27
Alfred Nobel: il più grande paraculo della storia
Il Premio Nobel: altissimo riconoscimento accademico, nasce dal tentativo di…