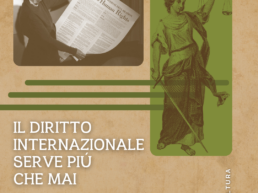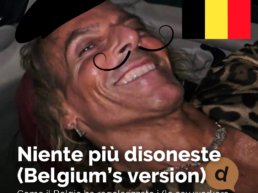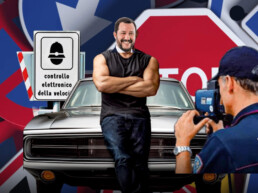La Giornata mondiale dei diritti umani offre lo spunto per parlare di ergastolo, un istituto che ha sempre generato accesi dibattiti. È ammissibile che uno Stato rinchiuda a vita un uomo? Scopriamolo insieme.
Introduzione
Il 10 dicembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani, giorno in cui le Nazioni Unite hanno adottato la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che ha dato pieno riconoscimento alla dignità di tutti gli uomini e del loro diritto all’uguaglianza, alla libertà e alla pace.
Mi sembra allora opportuno parlarvi dell’ergastolo, un istituto che più e più volte ha suscitato dubbi e contrasti mai risolti del tutto a scapito, appunto, dei diritti umani, e che in questi giorni è riapparso nel dibattito dopo le condanne di Turetta e Impagnatiello per i femminicidi di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano.

Il quadro normativo
Andiamo con ordine e partiamo dalle norme, che è la frase mi ripetono più spesso agli esami. Prima di tutto, il Super Saiyan delle leggi: la Costituzione. All’art. 27 leggiamo che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni condannato ha diritto a un trattamento dignitoso e, soprattutto, che la pena inflitta deve tendere alla sua rieducazione, al suo reinserimento nella società.
Secondo l’art. 22 cod. pen. la pena dell’ergastolo è perpetua. È sempre così? Non proprio, perché vi sono diversi meccanismi che consentono al condannato, dopo aver scontato determinati anni con buona condotta, l’accesso a benefici – come i permessi premio – e alla liberazione condizionale, prevista dall’art. 176 cod. pen., in forza del quale il condannato che ha scontato almeno 26 anni di pena può essere rimesso in libertà.

Ma allora qual è il problema? Il problema nasce da una particolare ipotesi di ergastolo: l’ergastolo ostativo, forma di ergastolo che non prevede la concessione di benefici. Anche qui, andiamo con ordine. L’art. 4-bis (non il 41-bis, che è un’altra cosa e ne riparleremo) della legge 354/1975 stabilisce che i benefici – ma non la liberazione condizionale – possono essere concessi ai condannati per alcuni delitti gravi, come terrorismo ed associazione mafiosa, solo se questi collaborano con la giustizia. In assenza di collaborazione si resta in carcere a vita e, per questo, si parla di “fine pena mai”.
A questo punto, la domanda che viene da porsi è: come fa una condanna perpetua a conciliarsi con la rieducazione del condannato? O, come ho scritto nel sottotitolo: è ammissibile che uno Stato rinchiuda a vita un individuo? Ecco, questo è il punto su cui si concentra la discussione giuridica sulla figura dell’ergastolo.
Piccoli rammendi
Quindi, l’articolo 4-bis (quello di prima) non permette di concedere permessi premio ai condannati, per determinati reati, che non collaborano con la giustizia. Il ragionamento di fondo è che, se non collabori, sei ancora affiliato con la malavita. La Corte costituzionale è intervenuta a gamba tesa sull’argomento con la sentenza 253/2019, in cui ha dichiarato illegittimo l’articolo 4-bis.
Il ragionamento della Corte è semplice: se collaborare può essere una scelta fatta solo per ottenere i benefici, allo stesso modo la non-collaborazione non può essere interpretata solo ed esclusivamente come fedeltà alla criminalità organizzata. Secondo la Consulta, infatti, i motivi della non collaborazione possono essere tanti (come la paura di ripercussioni); per questo motivo, ha aperto alla possibilità di concedere permessi nel momento in cui ci si accerta che non ci sono più legami con la malavita. Così facendo, tuttavia, non si è pronunciata sulla liberazione condizionale.

Il ragionamento della Corte è semplice: se collaborare può essere una scelta fatta solo per ottenere i benefici, allo stesso modo la non-collaborazione non può essere interpretata solo ed esclusivamente come fedeltà alla criminalità organizzata.
Inoltre, secondo i giudici è proprio la possibilità di ottenere la liberazione condizionale che rende l’ergastolo compatibile con l’art. 27 della Costituzione e con la finalità rieducativa della pena. Compatibilità che viene meno nella versione ostativa e, per questo, la Corte ha dato al legislatore l’incarico di riparare questa rottura ma, purtroppo, il Governo non è stato ancora affidato a Bob l’aggiustatutto ed eccomi qui a farvi compagnia.
Ma davvero ce ne siamo accorti solo ora?
A questo punto potrei chiudere l’articolo e lasciarvi a riflettere sull’ergastolo, ma non posso perché la nostra linea editoriale esige qualche parola in più. Vi propongo allora un’ultima riflessione, meno tecnica e più filosofica, per mostrarvi che il carcere a vita non lo tolleravano già nel XIX secolo, tant’è vero che alcuni preferivano la pena di morte (non tutto deve avere un senso ma per Bentham ne aveva e come).
Secondo Beccaria, lo Stato nasce con il contratto sociale. Con esso l’uomo entra in società e, per farlo, cede una minima porzione della propria libertà per ottenere la tutela della restante parte, un po’ come quando accompagno la mia ragazza a fare shopping anche se non mi va solo per non litigare (scusa cara).

Il cittadino, però, vuole cedere solo quella minima porzione e niente più, allo stesso modo in cui accompagno la mia lei al Campania ma non voglio entrare da Sephora. Quindi, secondo Beccaria, il contratto sociale non può portare alla totale rinuncia al diritto alla vita (così come io non voglio vagabondare per tutti i negozi). Lo Stato, cioè, non può sopprimere del tutto la libertà di un uomo ma può al massimo limitarla.
Secondo Luigi Ferrajoli, lo studioso da cui ho tratto spunto perché magaaaari riuscissi a fare tutto ciò da solo, questo ragionamento mostra chiaramente come, nel momento in cui condanna qualcuno all’ergastolo, lo Stato entra in contrasto con sé stesso, ossia con il principio di tutela della vita umana che è posto alla sua base. E, da questo contrasto, discendono tutti i problemi di incompatibilità che abbiamo visto nei paragrafi precedenti.
Ecco, ora l’articolo è completo. Cari giustizialisti, non me ne vogliate.
Fonti
Se volete approfondire l’argomento, vi lascio qualche link:
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: che cos’è?
- Sentenza Corte costituzionale 253/2019.
- Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene.
- Luigi Ferrajoli, Il paradigma garantista.
- Sul contratto sociale ci sono fiumi di pagine, vi lascio un link al sito Treccani.
2025-05-28
Il referendum: una botta di… quorum
È arrivato il momento di affrontare il fattore quorum nei referendum: perché…
2025-04-14
Biancaneve abusiva: rischia la galera?
Biancaneve fugge nel bosco, trova una casa e se ne appropria. Sai cos'è questo?…
2025-03-24
Femminicidio: un nuovo reato non ha senso
Il nuovo disegno di legge del Governo prevede l’ergastolo per chi uccide una…
2025-02-21
Il diritto internazionale serve più che mai
Tra guerre, tensioni diplomatiche e mandati respinti, il diritto internazionale…
2025-01-10
Niente più disoneste (Belgium’s version)
Mentre sui social spopolano i meme su “disonesti/e”, il Belgio riconosce ai…
2024-11-25
Nuovo Codice della Strada: ma siamo seri?
Con le ultime modifiche al Codice della Strada, l'Italia sceglie nuovamente di…
2024-11-12
God save America(ns)
Denunce, Vip, sparatorie, tensioni… No, non è una sommaria descrizione della…
Autore
-
Ho 24 anni e studio giurisprudenza. Mi piacciono la filosofia del diritto, la politica e la pizza würstel e patatine. Ah sì, mi piace anche scrivere.
Visualizza tutti gli articoli