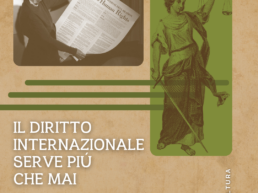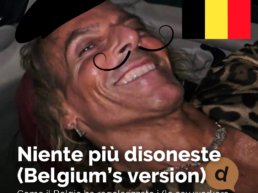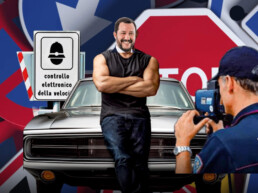Denunce, Vip, sparatorie, tensioni… No, non è una sommaria descrizione della Milano by night ma il palcoscenico che ha fatto da sfondo all’elezione del 47º Presidente degli Stati Uniti d’America: Donald Trump.
Teatralità.
Se è vero che agli americani piace esagerare, è altrettanto vero che questa tornata elettorale sarà difficilmente dimenticata. Dagli scontri al Campidoglio del 6 gennaio 2021 la politica statunitense è stata segnata da incidenti, processi e vicende che hanno portato alla spaccatura del bacino elettorale nei due contrapposti poli rappresentati da Kamala Harris e Donald Trump. Un periodo frizzante tra la messa in stato d’accusa di Donald Trump, il Presidential Debate del 27 giugno scorso dove Biden è apparso “così confuso da colpirsi da solo” fino a luglio, quando Donald Trump ha rischiato di rimetterci le penne per un colpo di fucile.
Insomma, tra il vecchietto sostituito dalla nipotina e il tycoon criminale che sopravvive a un attentato abbiamo una sceneggiatura degna di Hollywood.

Un rapido sguardo al sistema elettorale americano.
Gli States non potevano non distinguersi anche per il sistema elettorale. Il popolo non elegge direttamente il Presidente ma, quando va alle urne, vota per eleggere i Grandi Elettori che poi votano per il loro candidato (in questo caso Trump e Harris). La battaglia elettorale riguarda quindi i 538 delegati, ripartiti tra i vari Stati su base demografica: si va dai 54 della California ai 3 dell’Alaska. Per assegnare i delegati ai due candidati si applica la regola “winner takes all”: chi ottiene più voti in quello Stato vince tutti i delegati previsti. Terminate le elezioni, diventa presidente chi ottiene almeno 270 delegati, ossia il 50%+1 del totale. Il voto popolare non è quindi decisivo quanto il voto dei grandi elettori e, infatti, nel 2016 Hillary Clinton ha perso le elezioni con un numero di voti popolari superiore a quello di Trump ma un numero inferiore di delegati.
Sì, è un sistema complicato ma contenti loro contenti tutti.
Esito.
Nella notte italiana tra il 5 e il 6 novembre, a scrutini ancora in corso, Trump si è proclamato vincitore, forte della vittoria negli Swing states di Pennsylvania e North Carolina e della prevalenza su Kamala negli altri 5 Stati in bilico (Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin e Nevada).
Trump ha guadagnato voti in qualsiasi gruppo demografico, aumentando significativamente con ispanici e giovani e, seppur di meno, con l’elettorato afroamericano. Notiamo, quindi, come abbia attinto alla base elettorale dei democratici come, ad esempio, con i neri: pur avendo raggiunto l’80%, infatti, Kamala ha perso ben 10 punti percentuali rispetto al risultato di Biden del 2020.
Ancora, Trump prende il largo tra gli ultracinquantenni bianchi e, guardando alle preferenze ripartite per titolo di studio, prevale tra coloro che non hanno frequentato il college così come Kamala tra coloro che hanno conseguito PhD (il nostro dottorato di ricerca, per capirci) e simili.

Insomma, Trump è tornato e lo ha fatto in grande: i repubblicani hanno vinto il voto popolare per la prima volta dopo 20 anni e per la seconda volta negli ultimi 36, quindi può godere di un’ampia investitura popolare. Come ha scritto il politologo Ian Bremmer su X “onda rossa è riduttivo”.
Com’è stato possibile? Principalmente per due fattori. In primis, per l’abilità nel parlare alla pancia delle persone. Donald Trump non era l’ex Presidente ma era ed è Donald Trump. E se nonostante sentenze, accuse, scandali – e chi più ne ha più ne metta – riesci a diventare una guida per circa 72 milioni di persone, di abilità devi averne tanta. In poche parole: vedono Trump come una star a cui si può perdonare tutto e, forse, farebbero bene a mettere gli occhiali.
Secondo fattore è l’aiuto che gli hanno dato i democratici. Andare avanti con un Biden in quello stato fino a 5 mesi dalle elezioni e sostituirlo all’ultimo con Kamala ha contribuito a portare gran parte degli elettori a preferire un ritorno al passato per la mancanza di alternative valide per il futuro.
E ora che succede?
Come illustrato in precedenza, la procedura di voto è indiretta. Chiuse le urne e terminato lo spoglio, la palla passerà dunque ai grandi elettori che, entro il 17 dicembre, voteranno a loro volta il nuovo presidente. Il 6 gennaio, il Congresso conterà i voti dei grandi elettori e proclamerà il vincitore che, il 20 gennaio, presterà il giuramento come nuovo Presidente degli Stati Uniti. Solo in quel momento inizierà il secondo mandato di Donald Trump, che resterà in carica per i successivi quattro anni.

Cosa dobbiamo aspettarci da Trump?
Nel suo programma elettorale, Trump si è concentrato maggiormente sui classici temi conservatori, come lo stop all’immigrazione clandestina, definita addirittura invasion, la modernizzazione dell’esercito e l’immancabile apologia del diritto a possedere armi. Particolari – ma anche abbastanza prevedibili – sono la previsione del taglio dei finanziamenti alle scuole che promuovono la gender ideology e altri “inappropriati contenuti politici e sessuali” e lo slogan keep women out of men’s sport.
Sul versante interno, tuttavia, il tema ricorrente e decisivo di queste elezioni è stato sicuramente l’aborto. Sul punto, la CNN ha constatato come Trump abbia cambiato idea sull’aborto 15 volte in 25 anni, passando da posizioni pro-choice e, successivamente, pro-life, a dichiarazioni in cui afferma che «il medico o qualsiasi altra persona che compie questo atto illegale (l’aborto) su una donna sarebbe ritenuto legalmente responsabile, non la donna». Più di recente, è sembrato favorevole ad un divieto federale di aborto a 15 settimane salvo eccezioni ma, di seguito, ha dichiarato che non firmerà alcun divieto nazionale di aborto. Evitando di riportare le esternazioni più pittoresche, ad esempio quando ha affermato che i democratici intendono fare strage di bambini, la conclusione che si può trarre è che non voglia sbilanciarsi più di tanto perché consapevole del fatto che posizioni troppo a favore e posizioni troppo contro possano pregiudicare la sua popolarità. Non è un caso, dunque, che l’unico punto su cui il neoeletto Presidente continui a spingere è la possibilità che ogni Stato disciplini autonomamente l’aborto, ponendosi in continuità con la sentenza Dobbs di una trumpiana Corte Suprema che ha ribaltato la storica pronuncia Roe v. Wade del 1973 – che andrebbe approfondita, ma se scrivessi altre 1400 parole il caporedattore mi taglierebbe la testa – di cui Trump si è da subito preso il merito.
Quali che siano le scelte di Trump sul piano interno, è ovvio che il punto di maggior interesse sia la politica estera, soprattutto riguardo le scelte che The Donald prenderà circa il conflitto israelo-palestinese e quello russo-ucraino.
Il principale slogan di Trump in materia, ripetuto negli ultimi anni come un mantra, lo conosciamo tutti: “fermerò le guerre in 24 ore”. Ma come ha intenzione di farlo?

Quanto al Medio Oriente, secondo molti analisti, è facile immaginare che Trump lasci carta bianca a Netanyahu. In diverse occasioni, infatti, ha definito Israele un cherished ally e ha annunciato di stare con orgoglio al suo fianco. Il Trump I, come lo chiamerebbero i nostri quotidiani, si è concentrato molto sull’isolamento dell’Iran – definito “il principale sponsor del terrorismo” – arrivando a ritirarsi dall’accordo sul nucleare e a reimporre sanzioni economiche al paese. Uno scenario, quello della pressione sull’Iran, che potrebbe tornare a riproporsi sia con nuove sanzioni volte a tagliare i finanziamenti di Teheran ad Hamas, Hezbollah e miliziani Houti sia con l’appoggio ad Israele per eventuali azioni mirate contro l’Iran, in netto contrasto con la Harris che, fermo restando il supporto ad Israele, ha almeno manifestato preoccupazione per la sofferenza civile a Gaza e chiesto più volte la cessazione delle ostilità. In sostanza, Trump fa orecchie da mercante verso la questione palestinese e in questa direzione vanno due esternazioni fatte nel corso della campagna elettorale. In primo luogo, durante il Debate, alla domanda sullo stato palestinese, ha risposto semplicemente “Dovrei vedere”. In secondo luogo, ha invitato Benjamin Netanyahu a “fare ciò che deve fare” e a “concludere la guerra”. Un “vado al prossimo appello” insomma. A questo punto è necessario porsi una domanda: cosa farebbe Trump se Israele decidesse di attaccare l’Iran? Un Iran che, anche se in difficoltà, non è lo stesso del 2016 e che è molto vicino proprio a Russia e Cina in seguito all’ingresso nel gruppo dei Brics. La risposta è una: non si sa, nessuno lo sa. Per Bibi (Netanyahu), la tanto agognata elezione di Trump rischia quindi di rivelarsi niente più che una scommessa moooolto azzardata.
Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, la situazione è più complessa, da un lato, per il numero degli interlocutori, ossia Ue, singoli alleati europei e Nato, in passato criticata da Trump, e, dall’altro, per due fattori di segno opposto: gli 85 miliardi di dollari spesi per supportare Kiev e il danno che deriverebbe agli Stati Uniti in caso di abbandono improvviso del supporto stesso. Per questo, Trump punta alla conclusione del conflitto con la Russia ed è pronto, secondo le dichiarazioni rilasciate durante la campagna elettorale, a partecipare a un progetto di pace in cui l’Ucraina potrebbe dover cedere dei territori e restare neutrale (niente Nato) in cambio della fine delle ostilità. Ma che ne sarà dell’Ucraina all’indomani di un tale accordo? Quali garanzie avrà Kiev contro un’altra invasione russa? Dal momento che Trump lascerebbe tutto nelle mani dell’Europa che non ha né la forza né l’intenzione di opporsi militarmente a Putin, la risposta è: nessuna. Anche in questo caso, dunque, si opta per soluzioni rapide per concentrare gli sforzi dell’amministrazione in altri contesti, come la competizione con la Cina e i problemi interni.
Altro tema che desta timore e che del pari va in direzione MAGA (Make America Great Again) è quello dei dazi. L’intenzione di Trump dovrebbe essere quella di aumentare del 10-20% i dazi sulle merci che vengono importate dagli Stati Uniti, allo scopo di proteggere l’industria e penalizzare gli avversari di mercato. Dazi che verso la Cina arriverebbero al 60%. Saranno davvero dazi amari.
Conclusioni
Questo ritorno, in ogni caso, fa sorgere molti interrogativi su diritti riproduttivi, relazioni internazionali e, nello specifico, sulla posizione che gli Stati Uniti assumeranno nel mondo che verrà dopo le elezioni. Se veramente sarà America first allora la prospettiva è quella di un disimpegno sempre maggiore degli Usa nelle questioni di primaria importanza nelle agende degli altri Stati, specie quelli europei. Ma, del resto, una tale prospettiva non sembrava evitabile con l’elezione della Harris.
Proprio l’approccio ai problemi internazionali, sia di Trump che della sconfitta Harris, dimostra come la tipica isteria per le elezioni a stelle e strisce possa rivelarsi nient’altro che fumo negli occhi del mondo e che, a prescindere dall’inquilino della White House, gli Stati Uniti siano orientati a tutelare sé stessi, impegnandosi principalmente sul fronte interno.
2025-05-28
Il referendum: una botta di… quorum
È arrivato il momento di affrontare il fattore quorum nei referendum: perché…
2025-04-14
Biancaneve abusiva: rischia la galera?
Biancaneve fugge nel bosco, trova una casa e se ne appropria. Sai cos'è questo?…
2025-03-24
Femminicidio: un nuovo reato non ha senso
Il nuovo disegno di legge del Governo prevede l’ergastolo per chi uccide una…
2025-02-21
Il diritto internazionale serve più che mai
Tra guerre, tensioni diplomatiche e mandati respinti, il diritto internazionale…
2025-01-10
Niente più disoneste (Belgium’s version)
Mentre sui social spopolano i meme su “disonesti/e”, il Belgio riconosce ai…
2024-12-10
Ergastolo: un problema di coerenza
L' ergastolo: un istituto che ha sempre generato accesi dibattiti. È…
2024-11-25
Nuovo Codice della Strada: ma siamo seri?
Con le ultime modifiche al Codice della Strada, l'Italia sceglie nuovamente di…
Autore
-
Ho 24 anni e studio giurisprudenza. Mi piacciono la filosofia del diritto, la politica e la pizza würstel e patatine. Ah sì, mi piace anche scrivere.
Visualizza tutti gli articoli