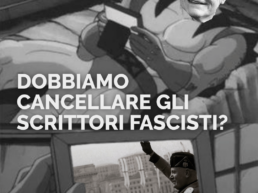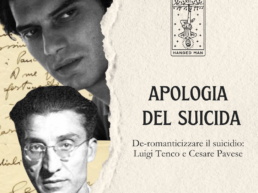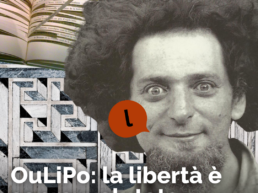Ho letto la quadrilogia de L’amica geniale in circa un mese. Mi è piaciuta tantissimo, così tanto che mi sono messo a cercare informazioni sui romanzi e sull’autrice, nascosta dietro lo pseudonimo “Elena Ferrante”. Non l’avessi mai fatto: mi sono ritrovato tra coloro che sostengono che l’autrice sia un uomo. Ma se lo pseudonimo è femminile e le protagoniste dei romanzi sono donne, perché pensarlo? Facciamo un po’ di chiarezza.
Elena Ferrante è lo pseudonimo di una scrittrice italiana, la cui vera identità è rimasta avvolta nel mistero fin dal suo debutto letterario con L’amore molesto, pubblicato nel 1992. Ferrante ha conquistato fama internazionale soprattutto grazie alla quadrilogia de L’amica geniale, una serie di romanzi che ha ottenuto un successo tale da portare il New York Times a dichiarare, il 12 luglio 2024, il primo volume come «il miglior libro del XXI secolo». Insomma, ‘na robetta.
Al centro dei libri di Elena Ferrante c’è la donna: le protagoniste dei suoi romanzi sono donne complesse e affascinanti. Uno degli aspetti più interessanti dei suoi romanzi è l’attenzione alle relazioni tra donne, vuoi che siano amiche o madre e figlia, in dinamiche profonde e mai stereotipate. Niente “donne angelo” o “donne demonio” nella penna di Ferrante, ma donne profonde, tormentate, che sgomitano per trovare un proprio posto nel mondo e per liberarsi dai condizionamenti familiari.

Chi è davvero Elena Ferrante?
Lo sappiamo, l’anonimato ci attira e ci incuriosisce. Pensiamo a Liberato: quante teorie e congetture ci sono dietro la sua figura? Nulla di nuovo, insomma, se c’è chi si impegna a “smascherare” l’autrice. Ma nel suo caso sono intervenute anche delle figure mistiche, estremamente puntigliose, spesso pelate: i filologi (zan-zan-zaaan!). E chi sono i filologi? Per i non addetti ai lavori, posso solo dire che i filologi sono degli studiosi che si occupano di analizzare, revisionare e ricostruire i testi nel tentativo di rispettare l’ultima volontà autoriale. Insomma, i rompiscatole della letteratura. Solo che senza di loro non avremmo testi qualitativamente validi, quindi non ci resta che ringraziarli.
Ma partiamo per gradi.
Sull’identità della Ferrante sono state fatte varie congetture: all’inizio sono saltati nomi improbabili, come quelli di Goffredo Fofi, Michele Prisco, Fabrizia Ramondino, persino Erri de Luca. Poi, rimanendo in area napoletana (l’esattezza di Napoli nei testi di Ferrante è un fattore da non trascurare) si è passati a Domenico Starnone e a sua moglie Anita Raja, entrambi amici degli editori della casa editrice E/O che ancora oggi pubblica i testi di Ferrante.
La possibilità che dietro l’autrice si nascondano due identità è stata avvalorata, secondo gli studiosi, dalla difformità dei libri firmati Ferrante: già tra il primo libro, L’amore molesto, e il secondo, I giorni dell’abbandono, il linguaggio presenta scarti notevoli, giustificabili però dal fatto che tra i due libri intercorrono ben dieci anni di distanza.
Nel 2005, lo studioso Luigi Galella pubblica sulla «Stampa» un saggio in cui mostra coincidenze significative con lo scrittore Domenico Starnone, in particolare tra il romanzo d’esordio di Ferrante e Via Gemito, proprio di Starnone. Da allora si arriva al 2016, con l’intervento di un vero boss: Marco Santagata. Ad alcuni questo nome potrà risultare anonimo: mi basta dirvi che la più recente edizione commentata del Canzoniere di Francesco Petrarca è curata proprio dal filologo appena citato. Non so se mi sono spiegato: è il Goku della filologia.
L'indagine di Santagata
Citando dettagli contenuti nel secondo libro della tetralogia, Storia del nuovo cognome (a mio parere il più bello dei quattro), sulla città di Pisa e la sua Scuola Normale Superiore che la protagonista Elena Greco frequenta per quattro anni, Santagata sostiene che la vera Elena Ferrante abbia frequentato la Normale di Pisa negli anni Sessanta e che sia originaria di Napoli o che ci abbia vissuto in seguito.
Tale affermazione è legata in particolare alle descrizioni di Pisa che sono presenti nel secondo libro: nelle pagine evidenziate da Santagata sono presenti tre elementi che hanno portato lo scrittore a supporre il soggiorno pisano dell’autrice.
Il primo è il lapsus su una famosa via di Pisa: Ferrante sbaglia la denominazione di una via scambiandola per un’altra sempre presente a Pisa, cosa che lascia pensare che l’autrice ci abbia realmente vissuto. Un altro aspetto interessante è l’uso del cosiddetto “lessico normalista”, ossia «l’imbattersi, nel testo, di alcune locuzioni piccole, […] difficilmente acquisibili attraverso una documentazione scritta, […] ma che sembrano scaturire da un vissuto.» L’uso di «il Timpano», ad esempio, che corrispondeva alla sede femminile della Normale, non era linguaggio comune dei pisani, ma regolare in quello dei normalisti. L’ultima prova che Santagata espone è legata a un personaggio del romanzo, Franco Mari, che pare somigliare a un ragazzo che ha frequentato la Normale in quegli anni, Adriano Sofri.
Nonostante alcune incongruenze messe in evidenza dallo stesso Santagata, lo scopo della ricerca dello studioso, alla luce delle riflessioni fatte, era di individuare una donna napoletana iscritta alla Normale negli anni della narrazione. Tutte queste caratteristiche hanno trovato riscontro in una sola donna: Marcella Marmo, una storica.

Marcella Marmo è Elena Ferrante?
Pare di no. La casa editrice E/O ha smentito subito la ricostruzione di Santagata, e così ha fatto Marmo, dichiarando di aver studiato a Pisa due anni ma di aver poi proseguito gli studi a Napoli, dove si è laureata. Marmo stessa dichiara di non avere una scrittura fantasiosa, ma di essere una persona razionale e di occuparsi di scritture rigorosamente storiche, come storia della camorra e del proletariato industriale a Napoli.
Possibile che Marco Santagata abbia sbagliato? E ora che si fa?
Si torna a Domenico Starnone e Anita Raja
Sempre nel 2016, Claudio Gatti sul «Sole 24 Ore» rivela di aver indagato sui movimenti economici della casa editrice e sui versamenti fatti da questa ad Anita Raja per non specificate collaborazioni, arrivando a speculare che dietro quei versamenti ci siano i diritti d’autore della sedicente Ferrante, a quel punto identificabile nella coppia Raja-Starnone. Cioè, Guarda di Finanza levati.
E guarda un po’, ecco la polemica. Del resto, perché mai arrabbiarsi se qualcuno ficca il naso nei tuoi conti?
Vengono poi indagini molto serie, come quella dello studioso Simone Gatto (Claudio Gatti, Simone Gatto… tutti felini) che nel 2018 dimostra numerose corrispondenze tra Via Gemito di Starnone e la quadrilogia, ricollegandosi allo studio del 2005. A seguire, sono giunte indagini algoritmiche, come quella stilometrica (che studia la similarità tra due testi) del centro svizzero «OrphAnalitics», che arrivò alla stessa conclusione. Insomma, anche per loro Ferrante è Starnone, opinione condivisa dal centro di Filologia Cognitiva di Paolo Canottieri e per i linguisti dell’Università di Padova Michele Cortelazzo e Arjuna Tuzzi.

Conclusioni
A questi studi ci tengo ad aggiungere giusto due cose.
Prima di tutto, non ho intenzione di criticare tutti questi studi, ma non riesco a condividere l’idea che dietro Ferrante ci sia un uomo. Non posso fornire “prove scientifiche” a riguardo, solo una riflessione da lettore. Leggendo i romanzi di Ferrante, si percepisce una narrazione che parte da un autentico punto di vista femminile. Mi risulta davvero difficile credere che un uomo possa replicare quelle finezze psicologiche che sembrano appartenere alla sensibilità di una donna.
Le protagoniste sono donne e pensano come tali; esprimono la loro condizione femminile nel contesto storico in cui vivono, affrontano la maternità in modo sincero, con tutte le sue complessità, evitando il mito della maternità come scopo unico o come esperienza sempre e solo idilliaca. Non escludo a priori che dietro Ferrante possa esserci Starnone; appare però più plausibile l’ipotesi di una scrittura condivisa con sua moglie.
Secondo: ma, in fin dei conti, che ce ne fotte? Scoprire o meno l’identità di Elena Ferrante non toglie niente alla qualità dei suoi romanzi; tutt’al più, aumenta le noie e le pressioni mediatiche sulla persona in carne e ossa – che, per nascondersi nell’anonimato, evidentemente di noie e pressioni non ne vuole. Elena Ferrante stessa, nel saggio La frantumaglia, ci offre il suo prezioso punto di vista: dietro l’anonimato si cela un desiderio di autoconservazione del proprio privato, un desiderio di mantenere una certa distanza. L’autrice (o autore, come si vuol dire) è convinta che i suoi libri non necessitino di una sua foto in copertina: devono essere organismi autosufficienti a cui la presenza dell’autrice non potrebbe aggiungere nulla di decisivo.
E se noi le vogliamo bene (e se non vogliamo che si rompa le palle e ci mandi tutti a quel paese rifiutandosi per sempre di scrivere) non possiamo far altro che rispettare questa sua chiara volontà.
Fonti
Il Corriere della Sera, Elena Ferrante, perché chiedere a Starnone di tirar giù la maschera non ha più senso
2025-06-04
Grammelot: la (non) lingua universale
Il grammelot: un non linguaggio capace di farsi comprendere da tutti.…
2025-06-02
Premio Strega: il più alcolico dei premi letterari italiani
Tra libri, figuracce ministeriali e il liquore giallo fluo: tutto quello che…
2025-04-25
Dobbiamo cancellare gli scrittori fascisti?
Un viaggio tra ideologia, poesia e memoria in occasione del 25 aprile. Come…
2025-03-21
Apologia del suicida – Tenco e Pavese
Un autore che si toglie la vita non è solo questo. Da Tenco a Pavese, ampliamo…
2025-03-07
OuLiPo: la libertà è sopravvalutata
Per l’OuLiPo, le regole non soffocano la creatività, la esaltano: ogni vincolo…
2025-02-07
Il romanzo è morto (o si sta evolvendo?)
Dai racconti su Instagram ai romanzi in stile social: il web sta cambiando la…
2024-12-06
Poema a fumetti: Orfeo ed Euridice sui Navigli
Dino Buzzati vive il Sessantotto con insofferenza. In realtà è in perfetta…
Autore
-
Il Caporedattore. Classe '00 come la farina. Laureato in Filologia moderna. Mamma dice che sono carino.
Visualizza tutti gli articoli