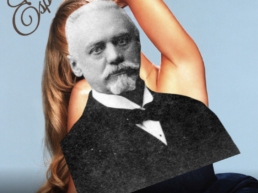C’è chi li chiama “lingue madri” e chi li deride come storpiature. Ma i dialetti italiani sono scrigni di storia, poesia e teatro. Dal napoletano di Totò al siciliano di Camilleri, passando per Goldoni e Deledda, ecco perché non possiamo farne a meno.
Perché parlare di dialetti oggi?
Innanzitutto, che cos’è un dialetto? Con questo termine ci riferiamo a varietà linguistiche non standardizzate, tendenzialmente ristrette all’uso orale in una determinata comunità di parlanti, ed esclusa da impieghi formali ed istituzionali, propri invece delle lingue. Anche quello che oggi chiamiamo italiano nasce da un dialetto, che però ha avuto più fortuna degli altri fratelli: quello toscano, fiorentino in particolare, assurto al rango di lingua nazionale in seguito a vicende storico-politico-culturali avvenute tra il XIV e il XVI secolo.
L’ascesa al trono del fiorentino ha relegato automaticamente al rango di dialetti tutte le altre parlate. Questo significa che se la storia fosse andata diversamente, qualsiasi altro dialetto italiano avrebbe potuto essere oggi la base per la nostra lingua.

L’Italia nasce politicamente unita solo nel 1861, ma culturalmente è rimasta profondamente plurilingue. In un paese come il nostro, dove ogni città è un microcosmo, i dialetti non sono derivazioni scorrette dell’italiano, ma evoluzioni autonome del latino volgare, contaminate da dominazioni, commerci, migrazioni. Hanno strutture sintattiche proprie, fonetiche uniche e patrimoni lessicali spesso più ricchi dell’italiano standard.
E soprattutto: parlano dritto alla pancia e al cuore.
In questo contesto, i dialetti di cui ci occupiamo oggi (napoletano, siciliano, veneto e sardo) non sono solo dialetti: sono lingue. La loro sopravvivenza non è un accidente del folklore, ma una forma di resistenza culturale.
Veneto: tra maschere e pronomi clitici

Il veneto non è solo la lingua dei veci che bevono l’ombra in osteria. È una lingua vera, riconosciuta da molti linguisti come lingua a sé stante. Ciò significa che viene riconosciuto come una lingua autonoma, con una propria storia, struttura linguistica e tradizione letteraria.
Sintassi autonoma, morfologia tutta sua, e quei benedetti pronomi clitici soggetto che ti bastano per riconoscere un veneto ovunque, anche se è a Tokyo in mezzo a una comitiva di giapponesi. Basta che tiri fuori un “el parla” e tu sai subito da dove viene.
In più, il veneto ti regala:
- la degeminazione, se non l’annullamento, delle consonanti sonore geminate: [mìe] mille, [kàramɛa] caramella.
- caduta delle vocali finali nel veneto settentrionale: [ros] rosso, [quist]questi,
Giusto per fare alcuni esempi.

Il più illustri scrittore veneto è certamente Carlo Goldoni, che prende la sua lingua e la mette in teatro, smontando la Commedia dell’Arte con le sue maschere e scrivendo per gente vera.
Il dialetto era per lui uno strumento per rappresentare la società veneziana del Settecento, con tutte le sue sfumature. Ha fatto per il veneto quello che Dante ha fatto per il volgare toscano, ed è stato proprio lui a contribuire in modo significativo allo sviluppo della letteratura dialettale.
Facciamo un esempio pratico: prendiamo “I rusteghi”, una sua commedia, precisamente una frase della prima scena:
Ve feu maraveggia per questo? Mi gnente affatto. Xe debotto sedese mesi, che son maridada; m’alo mai menà in nissun liogo vostro sior padre? (Vi stupite per questo? Io per niente. Sono già sedici mesi che sono sposata; vi pare che vostro padre mi abbia mai portata da qualche parte?)
Qui il linguista si sfrega le mani. Per esempio:
- “Ve feu maraveggia”: feu (fate) è forma arcaica per fate voi, mentre maraveggia è “meraviglia”, sorpresa.
- “Mi gnente affatto”: ellissi del verbo, che resta sottinteso. “Io niente per nulla” = “Io non mi stupisco affatto”. Tipica costruzione veneta ellittica.
- “Xe debotto sedese mesi”: xe corrisponde a “è” (dal latino est), debotto = “ormai da”, sedese = “sedici”, che mostra la trasformazione da sedici → sedese (conservazione della struttura sillabica originale).
- “vostro sior padre?”: sior = “signor”, forma sincopata e affettuosa, tipica dell’uso veneziano per riferirsi a un padre autorevole ma non idealizzato.
Sardo: l’erede più fedele del latino
Il sardo è un fossile vivente della lingua latina, ma vivo e pulsante. È probabilmente la lingua romanza più conservativa d’Europa. Il sardo ha un sistema fonologico arcaico, una grammatica solida e varietà interne molto forti, tra cui le principali: logudorese e campidanese. È una lingua che si è evoluta per i fatti suoi, lontana dal toscano e da ogni standardizzazione.

Foneticamente, è un pugno sul tavolo: /k/ e /g/ si mantengono come nel latino conservando suoni che l’italiano ha perso da secoli. Ad esempio, centum (latino) in italiano è “cento”, in sardo è kentu, con la C dura originale.
Un altro tratto particolare (ma condiviso con altri dialetti) è la metafonia, un fenomeno linguistico in cui la vocale tonica della parola cambia in base alla vocale finale (di solito una i o una u). È presente soprattutto nel logudorese.
- bonu (buono) → benu (buoni)
- manu (mano) → menu (mani)
La prima (e finora unica) scrittrice italiana a vincere il Nobel per la Letteratura, Grazia Deledda, ha scritto in italiano. Ma le sue storie, la mentalità dei personaggi, i paesaggi, sono profondamente sardi. Il dialetto è lì, sotto traccia.
Nel suo stile sobrio e asciutto, il sardo pulsa dietro ogni frase. Ne troviamo tracce nel lessico: “tanca” (terreno di campagna chiuso da un recinto), “socronza” (consuocera), “corbula” (cesta), “bertula” (bisaccia). frate meu (fratello mio), su bellu mannu (il bellissimo, letteralmente il bello grande), a ti paret? (ti sembra?), corfu ‘e mazza a conca (colpo di mazza in testa), ancu non ch’essas prus (che tu non ne esca più: è un’imprecazione).

Anche in questo caso, i sardismi linguistici di Deledda non derivano da incapacità. Al contrario, sono una scelta estetica consapevole e precisa. Non era una che scriveva “così perché non sapeva fare meglio”: scriveva così perché sapeva benissimo cosa stava facendo. Portava nella pagina una lingua fatta anche di silenzi, ripetizioni, frasi brevi e colpi secchi, come quelli che si sentono nei racconti della nonna davanti al camino. E questa scelta non solo ha funzionato: ha lasciato un segno indelebile nella nostra letteratura.
Napoletano: una sinfonia di suoni e strutture
Il napoletano, classificato nel gruppo italo-romanzo meridionale, è uno spartito musicale vivo. Deriva dal latino, ma ospita tracce greche, arabe, spagnole e francesi.
Diciamolo subito: chiamarlo “dialetto” fa un po’ torto. Il napoletano è una lingua vera e propria. Ha una grammatica, una sintassi, un lessico ricchissimo e una diffusione che va ben oltre la Campania, e secondo alcuni linguisti dovrebbe essere classificato come lingua romanza autonoma, al pari del catalano o del provenzale. Ma il dibattito è ancora acceso.

Partiamo dalla fonologia, che è unica: vocali tronche, raddoppi sintattici, apocopi e dittonghi che trasformano anche la frase più banale in qualcosa che ti resta addosso. Prova a dire “Aggio fatto tardi” e dimmi se non suona meglio di “sono in ritardo”.
Il napoletano ha prodotto poesia e musica come poche altre lingue. Dai versi di Giambattista Basile, autore de Lo cunto de li cunti, raccolta seicentesca di fiabe scritte in un napoletano letterario e ricchissimo, fino ai testi delle canzoni classiche napoletane: Reginella, ’O sole mio, Malafemmena. Prendiamo una poesia di Totò, A Franca:
Ammore, ammore mio,
chist’uocchie tuoie songo ddoje feneste
aperte, spalancate ‘ncopp’ ‘o mare;
m’affaccio e veco tutte ‘e ccose care
‘nfunn’a stu mare, verde comme l’uocchie tuoie:
e veco ‘o bbene, ‘o sentimento, ammore,
e assaje cchiù’nfunno ancora
io veco chello ca tu he dato a mme… ‘o core.
Rafforzamento sintattico? Sì, è quel raddoppio della consonante che senti in “a ccasa”. Apocope? La trovi ovunque: “cantà” invece di “cantare”. Rotacismo? La consonante /d/, sia in posizione intervocalica che iniziale, tende a trasformarsi in /r/. Ad esempio:
- dimane → rimane (domani)
- denare → renare (denari)
- madonna → maronna
E per fare giusto un altro esempio, il napoletano conserva oltre ai generi maschile e femminile, il anche il genere neutro, eredità del latino. Questo si evidenzia principalmente nell’uso dell’articolo determinativo singolare ‘o, che provoca il raddoppiamento fonosintattico della consonante iniziale del sostantivo che segue: ’o ppane (il pane), ’o ffierro (il ferro), ‘o bbene (il bene).
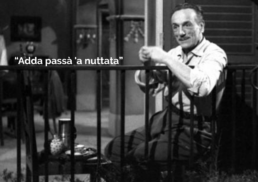
Eduardo De Filippo lo scolpisce in teatro con una forza inedita. In Napoli milionaria troviamo una delle frasi più celebri della drammaturgia italiana: “Adda passà ‘a nuttata”: sei parole che valgono un manuale di resilienza. Eduardo usa il napoletano per creare personaggi complessi, reali, dolorosamente vivi. Il dialetto non è decorazione, è carne, sangue e silenzio.
Ma Eduardo non è un caso isolato. Napoli ha sfornato voci teatrali e letterarie come una panetteria in servizio 24/7. Da Raffaele Viviani, che metteva in scena il sottoproletariato con una crudezza musicale, a Salvatore Di Giacomo, poeta e drammaturgo che fece del napoletano un linguaggio lirico e struggente.
Con tutti gli esempi che ci sono a Napoli non si finirebbe più: Enrico Caruso, Pino Daniele, Massimo Troisi, Salvatore Di Giacomo. Perché il napoletano è una lingua scenica per natura. Ogni quartiere ha i suoi modi di dire, ogni rione la sua variante, ogni famiglia il suo vocabolario tramandato a voce. La letteratura napoletana è un teatro continuo che va dalla strada al palcoscenico, dalla canzone alla poesia.
Siciliano: il dialetto della verità nuda
Anche il siciliano è un vero e proprio arcipelago linguistico: cambia da città a città, da quartiere a quartiere, ma mantiene ovunque un’identità forte e inconfondibile.
È una lingua romanza che si è sviluppata su un terreno fertile di dominazioni e scambi, ognuno dei quali ha lasciato tracce nella sintassi, nel lessico, nei suoni. Per esempio, abbiamo parole greche come trizzìa (tremore), parole arabe come zibbibbu (uva passa), catalane come picciottu (ragazzo), francesi come curtigghiu (cortile, ma anche chiacchiera).

Fonologicamente, il siciliano è un festival di sonorità uniche:
- Uso frequente dell’apocope e dell’elisione: fìmmina (donna) può diventare fimma, viri (vedere) resta tronca rispetto all’italiano. Il siciliano ama le parole essenziali, scavate.
- Sistema vocalico “aperto”: vocali come è e ò sono frequenti e aperte, dando alla lingua un suono cavernoso e profondo.
- Sonorizzazione delle consonanti: Le consonanti sorde (p, t, k, f, s) si sonorizzano (b, d, g, v, z) dopo le vocali o le consonanti nasali (n, m) e prima di una vocale. Esempio: “pìnnà” (penna) diventa “bìnnà”.
Prima ancora di Verga, il siciliano è stato la prima lingua d’arte e di poesia in Italia. Parliamo della Scuola Poetica Siciliana, fiorita alla corte di Federico II di Svevia nel XIII secolo: un esperimento colto e rivoluzionario in cui il volgare siciliano veniva usato per scrivere sonetti, canzoni e ballate d’amore, molto prima che Dante desse nobiltà al toscano.
E proprio Dante, nel De Vulgari Eloquentia, riconosce questo primato con rispetto quasi reverenziale: il dialetto siciliano, secondo il Sommo Poeta, è stato il primo a elevare il volgare a lingua poetica.
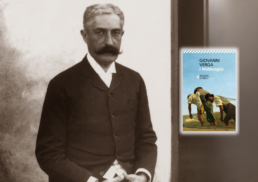
Con Giovanni Verga, il siciliano diventa scrittura. La principale vocazione del Verga è il linguaggio popolare, nel quale egli scopre immediatezza ed efficacia di contro all’artificiosa tradizione letteraria dalla quale vuole liberarsi. Infatti scrive in italiano, eppure il ritmo, le cadenze, le costruzioni sono chiaramente siciliane. È il famoso italiano dialettaleizzato, Ne I Malavoglia si fa potente. Prendiamo ad esempio:
“Padron ‘Ntoni scosse il capo e tirò avanti.”
L’uso dell’ellissi (“Padron ‘Ntoni” al posto di il padrone ‘Ntoni), la struttura paratattica, l’uso costante del discorso indiretto libero, fanno sì che il narratore e i personaggi parlino la stessa lingua. È letteratura che si abbassa per elevare.
E poi c’è il lessico: scaro, caruso, manciari, picciotti, gnucco; espressioni tipiche come “gnà” (signora), come in “gnà Mena”, “gnà Grazia”, e “gnà Venera”. Anche quando non scrive in siciliano stretto, Verga impasta l’italiano con la pasta madre del dialetto, e ne esce una lingua che sa di terra e sale.

E poi arriva Andrea Camilleri. Con Montalbano, inventa il vigatese, un misto di siciliano, italiano e lingua narrativa. Non è un dialetto puro, ma un’operazione letteraria che ha restituito al siciliano una centralità culturale popolare e colta allo stesso tempo.
“Montalbano sono!”
Frase-tormentone, ma anche dichiarazione di poetica. Il commissario usa il siciliano per muoversi nel mondo: è la lingua della sua realtà, della sua ironia, della sua giustizia.
Oggi non solo si parla, si scrive, si recita. E soprattutto: si tramanda. Perché il siciliano, come tutti i dialetti-lingua, non muore finché qualcuno lo usa per dire qualcosa di vero. E oggi i dialetti non sono solo nostalgia. Sono identità che si reinventa. C’è chi li rappa (Clementino), chi li memeizza, chi ci fa podcast.
Non c’è solo passato: c’è futuro. Perché la lingua di tua nonna può essere anche la tua, se ci credi ancora un po’.
E tu, quale dialetto parli?
2025-04-04
Linguaggio inclusivo: la grammatica può cambiare il mondo?
Linguaggio inclusivo, neutro, gender-sensitive: la lingua può davvero cambiare…
2025-03-03
Telefonate… geopolitiche: Russia, USA, Europa, Cina
Dalle telefonate con Putin alla trappola a Zelensky, Trump si è preso la scena…
2025-02-28
Linguistica e AI: chi comanda davvero?
L’IA è un’enciclopedia turbo, ma senza di noi resta muta. La linguistica è il…
2025-02-17
Articoli scientifici? Roba da gatti!
Fisica quantistica e gatti? Sì: F.D.C. Williard, un siamese, ha ben due…
2024-12-20
DanDaDan, UFO e fantasmi: l’ossessione per l’ignoto
Gli UFO stimolano il nostro immaginario dagli anni '50. Lo sa bene DanDaDan,…
2024-11-19
Il brevetto che ci ha svegliati: nasce l’espresso italiano
19 novembre 1884: un torinese registra il brevetto che avrebbe reso la caffeina…